La mini saga di MondoNove è arrivata al capitolo conclusivo. A trent’anni dal naufragio che decretò l’inizio della sua avventura, la “Robredo” si prepara al duello con un pachiderma mille volte più grande. Un assaggio della fine, in compagnia dell’unico superstite di allora, il comandante Garrasco…
Acqua. A secchiate.
Il cielo nero la rovesciava da ore. Senza respiro.
Percuoteva il metallo col suono lugubre di un diluvio di chiodi, ribollendo di schiuma biancastra.
Garrasco cercò di scrollarsela dalla faccia, scosse violentemente la testa da una parte e dall’altra, serrò le palpebre. Per il resto, ogni tentativo di evitarla era impresa vana. Non poteva muoversi. Era steso sulla schiena, a gambe larghe, il braccio destro ritorto dietro la nuca, vincolato al metallo da una forza che era più tenace di qualsiasi catena, più subdola di qualsiasi incantesimo. E più giù, i talloni… sembrava che avessero messo radici nel metallo.
Bevi, pensò tra sé. Bevi e ti farà meno male.
Raccolse un po’ di pioggia tra le labbra, storse la bocca e la risputò fuori con uno schizzo bavoso. Aveva un saporaccio da schifo, salatissima. Boccheggiò in cerca d’aria asciutta. Si dimenò.
Crampi. Lo stavano divorando vivo. Muscolo dopo muscolo.
Non era più un ragazzino (aveva superato da un pezzo i sessanta) e ogni volta che la misteriosa forza lo prendeva tra le sue braccia, stritolandogli ogni capacità di reazione, era sempre peggio.
Per un po’ osservò gli uccelli che volteggiavano in cielo: per loro la pioggia non era che il modo più rapido per ripulirsi dalla fuliggine delle ciminiere.
Si morse il labbro e batté violentemente la lamiera con il palmo libero.
Il metallo gli rispose quasi subito: tre colpi ravvicinati, pausa, due colpi…
Garrasco piegò gli angoli della bocca in una smorfia. Creatura era lì sotto, a pochi centimetri da lui.
Confortante ma di nessun aiuto pratico.
La pioggia diminuì via via d’intensità.
![]() Garrasco tese il collo, strinse i denti, con immane fatica staccò la nuca dal metallo e girò lo sguardo sulla sua prigione. Ogni centimetro dell’Afritania sembrava smaltato di vetro: torri, tralicci, cuspidi, alberi, spuntoni, traversine, balaustre, cupole, archi, scivoli, ciminiere, ponti, grondaie, comignoli, argani, gru, pulegge, ruote dentate… Torrenti d’acqua ruscellavano schiumando lungo strade e camminamenti, si abbattevano in cascate da passerelle e pontili. Una belva liquida che ogni volta si portava via tre o quattro uomini, affogati nella furia ribollente che travolgeva ogni superficie.
Garrasco tese il collo, strinse i denti, con immane fatica staccò la nuca dal metallo e girò lo sguardo sulla sua prigione. Ogni centimetro dell’Afritania sembrava smaltato di vetro: torri, tralicci, cuspidi, alberi, spuntoni, traversine, balaustre, cupole, archi, scivoli, ciminiere, ponti, grondaie, comignoli, argani, gru, pulegge, ruote dentate… Torrenti d’acqua ruscellavano schiumando lungo strade e camminamenti, si abbattevano in cascate da passerelle e pontili. Una belva liquida che ogni volta si portava via tre o quattro uomini, affogati nella furia ribollente che travolgeva ogni superficie.
La testa gli ricadde pesante sulla lamiera.
Creatura rispose con altri tre colpi, una pausa, due colpi.
Silenzio.
Il cielo si spezzò, aprendosi come labbri di una ferita. D’un tratto la pioggia cessò e tra le nuvole s’insinuò un sole indolente.
Garrasco rimase qualche minuto ad ansimare a bocca aperta. La mano destra gli cadde tra i capelli. Era libero. Serrò le gambe, raccolse le ginocchia al petto, si massaggiò il palmo per riattivare la circolazione. Aprì e chiuse diverse volte il pugno, osservando ogni volta il luccichio metallico delle unghie. Il Morbo cominciava dalle estremità e gli aveva già preso tre dita della destra e quasi tutto il dorso della mano, fino al polso. Era da lì che arrivava la sua prigione, la catena più forte di un incantesimo che, senza preavviso, lo trascinava a terra o contro una paratia e lo vincolava al metallo. Per ore, talvolta per giorni.
Si studiò i piedi. I talloni erano due noduli di ottone vecchio. Per il resto, il Morbo non pareva aver progredito di un millimetro, non ancora. Se Dio vuole, pensò, l’acqua piovana – salatissima – lo terrà a bada un altro po’.
Si aggrappò a un punzone che fioriva come un aculeo dal metallo e si tirò in piedi. Le ginocchia schioccarono, neanche fossero di legno. Mosse qualche passo sulle dita per non scivolare. Tutto sommato riusciva ancora a reggersi sulle proprie gambe; stante l’impeto del diluvio, era sicuro che altri non avrebbero potuto dirsi altrettanto fortunati.
A un paio di metri da lui vide l’uovo che stava trasportando. Era rotolato in una canalina di scolo, si era incastrato contro una grata e soltanto per un caso fortuito non era finito nel vuoto venti metri più sotto, per spiaccicarsi sulle sabbie velenose fuori dell’Afritania. Sembrava intonso, anche se un po’ ammaccato. Garrasco lo raccattò con due mani, se lo portò all’orecchio e lo scosse trattenendo il fiato.
Esalò un sospiro di sollievo. Era vivo. E vicino alla schiusa. Non poteva essere sicuro di che cosa contenesse esattamente, ma sapeva quanto fosse importante per l’Afritania: le uova erano ricambi freschi, innesti nuovi e su misura che sarebbero andati a occupare il loro spazio all’interno di un sistema dalla complessità paranoica. Per quanto la loro genesi fosse ancora in gran parte avvolta dal mistero, Garrasco sapeva che era la nave a dettarne il contenuto. E gli uccelli eseguivano…
Alla luce del tiepido sole che aveva fatto capolino tra le nubi stese lo sguardo sulla spianata di lamiere spalmate di riflessi. Dopo il lungo coma della tempesta, la città si stava lentamente ridestando. Il metallo si rianimava, l’acqua scivolava fuoribordo in rivoli sempre più esangui. Parecchi uomini, grandi come formichine di carne, si stavano dolorosamente tirando in piedi. Non tutti però.
Poi qualcuno gridò “Fiore!”. E poi ancora, più forte, “FIORE A DRITTA!”.
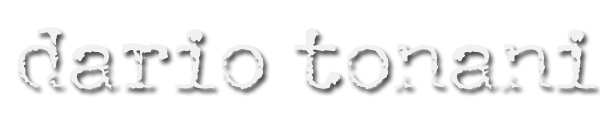


Lascia un commento